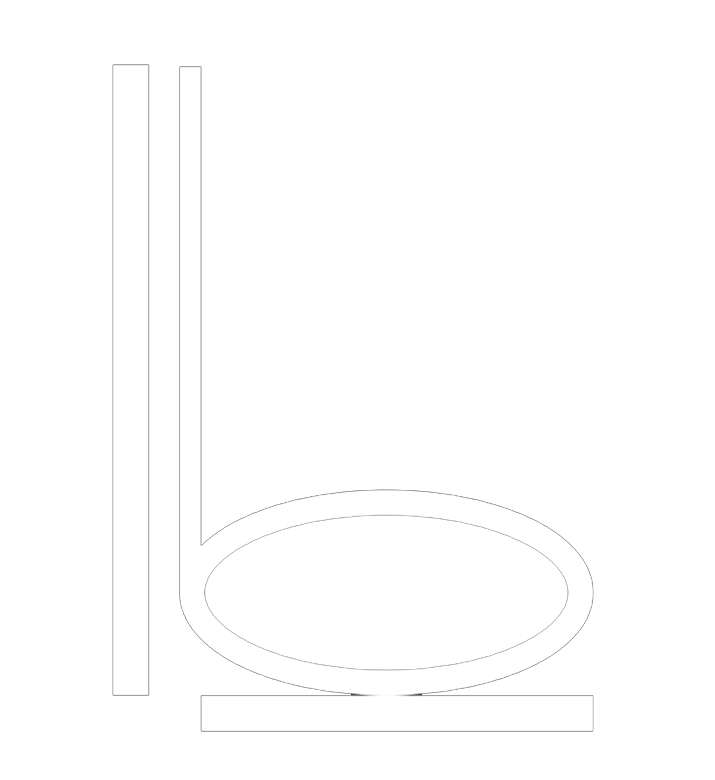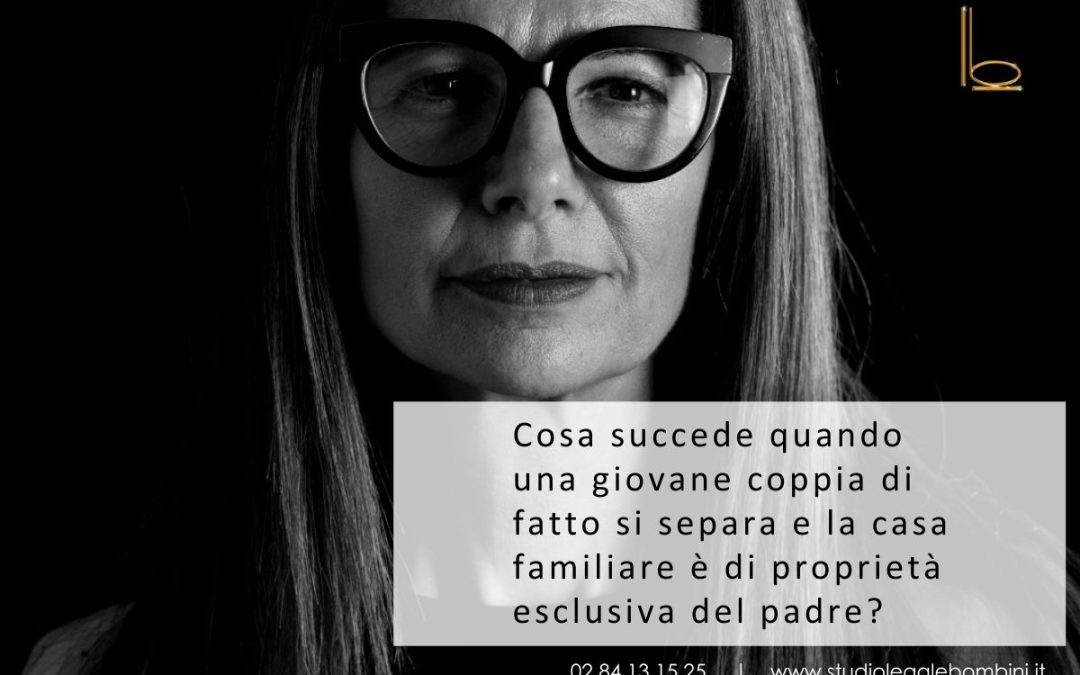Cosa succede quando una giovane coppia di fatto si separa e la casa familiare è di proprietà esclusiva del padre? L’affidamento paritario può rappresentare una svolta per tutelare non solo l’interesse del minore, ma anche i diritti del genitore proprietario.
Negli ultimi anni, il concetto di bigenitorialità ha preso piede anche nei tribunali italiani, superando gradualmente quell’impostazione culturale che identificava automaticamente la madre come genitore collocatario prevalente. Ma se da un lato l’ordinamento riconosce formalmente l’importanza del ruolo di entrambi i genitori nella crescita dei figli, dall’altro – in concreto – i padri continuano a essere penalizzati, soprattutto quando la casa familiare è di loro esclusiva proprietà. Questo articolo intende affrontare, da un punto di vista giuridico ma anche umano, la questione dell’affido paritario e dell’assegnazione della casa familiare in favore del genitore non collocatario, spesso il padre.
Il principio di bigenitorialità: evoluzione e significato attuale
Oggi, il principio di bigenitorialità non è solo un enunciato teorico, ma un elemento fondante del diritto di famiglia. Esso implica che, anche dopo la separazione, il figlio debba poter continuare a vivere un rapporto equilibrato, continuativo e significativo con entrambi i genitori. Non si tratta solo di condividere le decisioni, ma anche di dividere gli spazi, il tempo e la quotidianità. Negli anni, però, la prassi giudiziaria ha spesso limitato questo principio, prediligendo la madre come genitore collocatario e attribuendole la casa familiare, anche quando di proprietà esclusiva del padre. Questo ha prodotto non solo un disequilibrio affettivo nella relazione padre-figlio, ma anche un forte impatto economico e patrimoniale.
Affidamento paritetico e collocamento paritario: attenzione alla differenza
L’affidamento condiviso è ormai la regola nel nostro ordinamento: entrambi i genitori continuano a esercitare la responsabilità genitoriale. Tuttavia, è il collocamento del minore a determinare realmente l’equilibrio di potere e di presenza nella sua vita quotidiana.
Il collocamento paritario, in particolare, rappresenta una distribuzione equilibrata dei tempi di permanenza presso ciascun genitore. È su questo terreno che si gioca oggi la vera sfida della bigenitorialità. Quando è il padre a richiedere una simile modalità, spesso incontra maggiori resistenze culturali e pratiche, nonostante l’interesse del minore e i presupposti organizzativi lo rendano possibile.
Quando è possibile il collocamento paritario?
Il collocamento paritario non è imposto per legge, ma può essere disposto dal giudice se valutato conforme all’interesse del minore. I criteri principali sono:
- Prossimità delle abitazioni dei genitori
- Capacità genitoriale di entrambi
- Età e abitudini del bambino
- Clima di collaborazione tra i genitori
- Stabilità affettiva e relazionale
Anche in presenza di bambini piccoli, le più recenti pronunce, tra cui l’ordinanza n. 1486/2025 della Corte di Cassazione, hanno sancito che un collocamento paritario non può essere escluso solo in base all’età. Il vero parametro resta il benessere del minore.
Collocamento paritario e casa familiare: la questione della proprietà esclusiva del padre
Uno degli aspetti più delicati riguarda l’assegnazione della casa familiare. La normativa vigente stabilisce che, in assenza di accordo, la casa venga attribuita al genitore con cui il minore risiede prevalentemente. Questo principio, pur volto alla tutela del figlio, spesso finisce per penalizzare il genitore non collocatario, che nella maggior parte dei casi è il padre.
Se la casa è di proprietà esclusiva del padre e i figli vengono collocati prevalentemente presso la madre, quest’ultima avrà il diritto di abitarvi, mentre il padre sarà costretto a lasciare la propria abitazione. Con un doppio effetto negativo: da un lato, non potrà più godere del bene di sua proprietà, frutto magari di anni di sacrifici; dall’altro, sarà costretto a sostenere le spese straordinarie legate alla manutenzione dell’immobile, oltre a dover sostenere un canone di affitto per trovare un’altra sistemazione.
In caso di collocamento paritario, invece, non essendoci un genitore “prevalente”, l’assegnazione della casa non può più basarsi sulla sola convivenza dei figli con un genitore. In questa ipotesi, alcuni tribunali – come quello di Brindisi – hanno escluso l’assegnazione, restituendo al titolo di proprietà il ruolo centrale. Questo significa che il padre proprietario può continuare a vivere nella sua casa con i figli, in alternanza con l’altro genitore, riducendo i costi e preservando il proprio diritto di proprietà.
L’aspetto economico: mantenimento e parità di reddito
Molti padri si trovano, dopo la separazione, a dover affrontare un forte squilibrio economico: oltre a dover pagare un assegno di mantenimento, non possono godere della propria casa e devono affrontare ulteriori spese per affitto o mutuo. Il collocamento paritario può riequilibrare anche questo aspetto.
Se i tempi di permanenza sono uguali e i redditi sono comparabili, non c’è motivo per cui uno dei due genitori debba versare un assegno all’altro. Ognuno potrà sostenere le spese durante il proprio tempo di cura del minore. Le spese straordinarie, invece, potranno essere suddivise in misura proporzionale.
L’ordinanza della Cassazione del 2025 ha chiarito che non si può prevedere un assegno in modo automatico: occorre valutare caso per caso la capacità economica dei genitori e il reale contributo di ciascuno. Un contributo economico può essere disposto anche in caso di collocamento paritario, ma solo se strettamente necessario a garantire al figlio una vita dignitosa in entrambi i contesti.
A che età è possibile un collocamento paritario?
Non esiste un’età minima per il collocamento paritario. La Cassazione ha sottolineato che anche i bambini piccoli possono vivere stabilmente in due abitazioni, se ciò non compromette la loro serenità e se i genitori sono in grado di garantire continuità educativa ed emotiva. L’età non può più essere un alibi per escludere a priori il padre dalla quotidianità del figlio.
Un modello più equo per tutti
L’introduzione e il riconoscimento del collocamento paritario non rappresentano solo un diritto per il padre, ma soprattutto una garanzia per il figlio, che potrà crescere con entrambi i genitori in modo equilibrato. È tempo che anche il sistema giuridico e sociale recepiscano questo cambiamento, andando oltre le consuetudini del passato.
Laddove il padre sia proprietario della casa familiare e abbia dimostrato pari capacità e disponibilità nella cura del figlio, non è giusto che venga penalizzato. L’affidamento paritario, se correttamente applicato, permette di tutelare i diritti di tutti: quelli del minore, che conserva un rapporto stabile con entrambi i genitori; quelli del padre, che non viene estromesso dalla vita del figlio e dalla sua casa; e anche quelli della madre, che può contare su una condivisione effettiva delle responsabilità.
Rivolgersi a un avvocato esperto in diritto di famiglia può fare la differenza: ogni situazione ha le sue peculiarità e merita di essere affrontata con competenza, empatia e rispetto.
Contatta lo studio per ulteriori informazioni o per una consulenza.